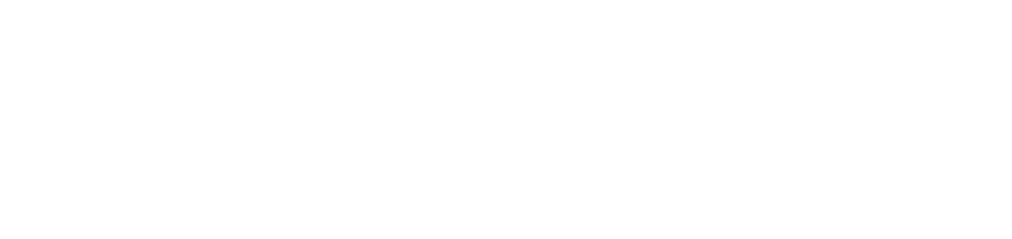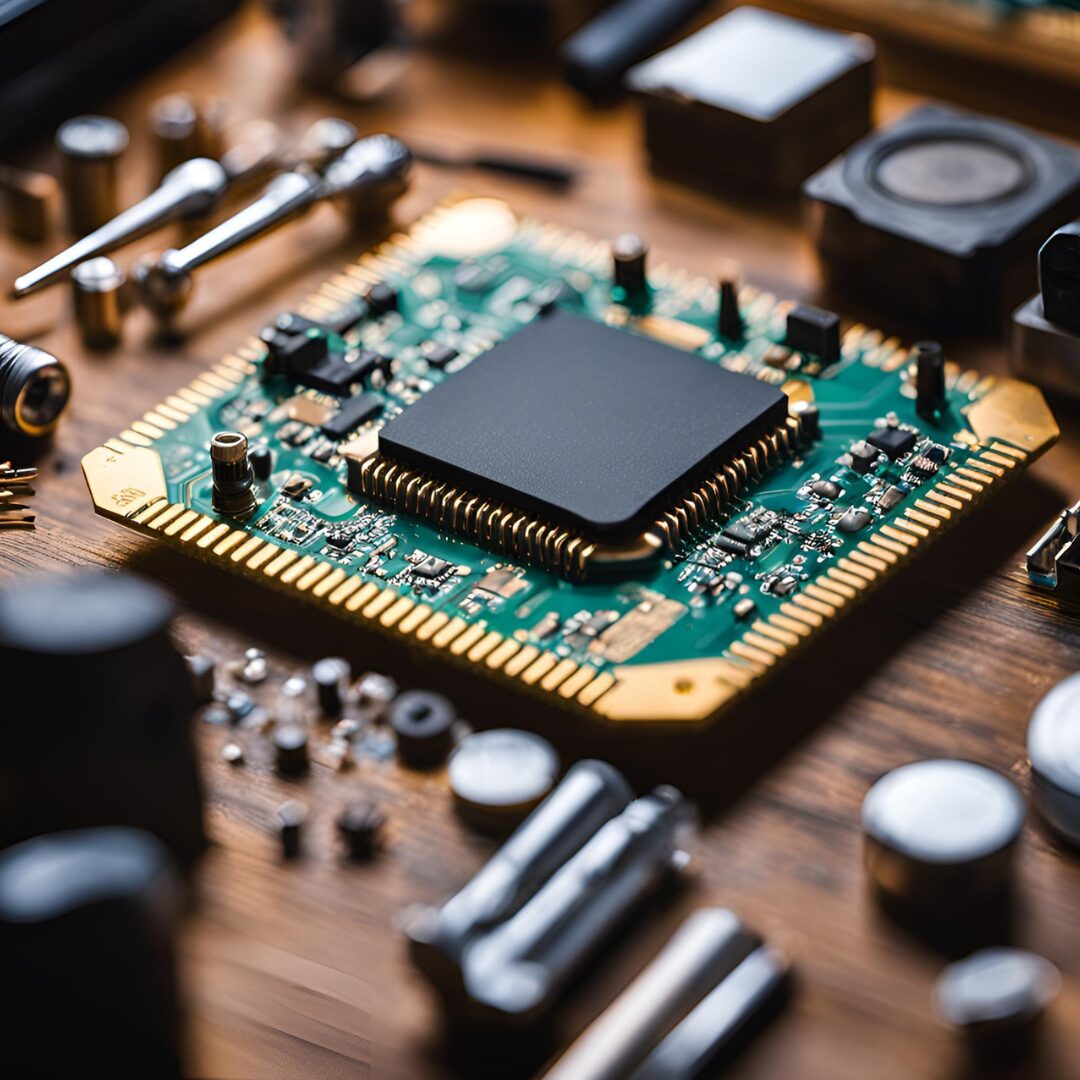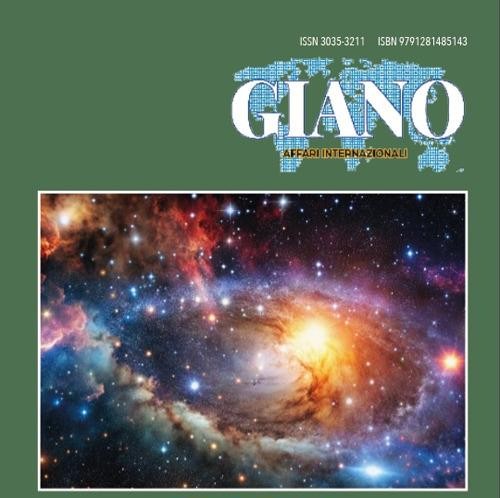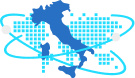Col 2025 si chiude la prima metà del decennio 202x che ha visto la geopolitica dei semiconduttori acquisire un rilievo e una risonanza raramente – e forse mai – viste in passato. Detonatore di questa esplosione di interesse è stata senza dubbio la pandemia da Covid-19 con la crisi della produzione delle automobili, innescata dalla mancanza di componenti a semiconduttore – i chip. L’impatto, anche a livello di opinione pubblica, degli ampi ritardi nella consegna di automobili con pesanti conseguenze economiche e sociali, ha sollecitato la presa di coscienza del ruolo strategico della microelettronica nella nostra società da parte della classe politica occidentale, come leva imprescindibile dello sviluppo economico, tecnologico, sociale. La microelettronica è la tecnologia abilitante della nostra vita quotidiana, che si basa sempre più insistentemente e pervasivamente sugli strumenti e sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tuttavia, dei 1000 miliardi di chip prodotti ogni anno ben tre quarti arrivano da fabbriche situate nell’estremo oriente, principalmente Cina, Taiwan, Corea e Giappone. L’Europa ha visto più che dimezzata la quota di mercato di chip prodotti nel continente dall’inizio del secolo ad oggi.
A partire dal 2022 sono così nati rapidamente piani ambiziosi di investimento pubblico e privato, ossia il Chips Act dell’Unione Europea e il CHIPS for America act negli USA, che mirano a riportare in Europa e negli USA capacità produttive migrate verso l’estremo oriente nei lustri precedenti. Migrazioni favorite sia da imprenditori capaci di sviluppare nuovi modelli di business come Morris Chang per TSMC a Taiwan, che dalla lungimiranza dei governi che hanno saputo sostenere con continuità lo sviluppo di tecnologie avanzate con azioni adeguate. Fra questi il governo cinese, a livello nazionale e provinciale, ha assunto un ruolo di guida e supporto, avendo sottolineato già nel 2014 l’importanza fondamentale di sviluppare una industria microelettronica nazionale, più volte ribadita dal presidente Xi Jinping.
In Europa ci siamo distratti (o abbiamo pensato che non valesse darsi pena per produrre chip che si potevano comprare facilmente in un mondo globalizzato) per alcuni lustri e adesso cerchiamo di recuperare il tempo e soprattutto il know-how perduto, con l’obiettivo ambizioso della Commissione Europea di riportare al 20% la quota dei chip prodotti in Europa sul mercato globale. Partiamo purtroppo da un livello basso, ben sotto il 10%, con una assenza pesante nei nodi tecnologici al di sotto dei 10nm e nei mercati dei componenti per la AI, GPU in testa, mentre rimaniamo ben posizionati su componenti per gli ambiti industriali e automotive, su cui però incombe la minaccia dell’invasione di auto elettriche cinesi. Al giro di boa del primo lustro degli anni’20 di questo secolo le prospettive non sono rosee. Intel, su cui Germania e Polonia avevano riposto ampie aspettative per fabbriche dedicate rispettivamente alla produzione e al test e all’assemblaggio di chip, dopo l’annuncio a metà 2023 della costruzione di queste fabbriche, a settembre 2024 ha deciso di posticiparne di almeno due anni la realizzazione per i gravi problemi che l’affliggono. A conferma delle difficoltà dell’azienda il CEO di Intel, Pat Gelsinger, si è dimesso il 1 dicembre scorso per l’insuccesso del suo progetto di rivitalizzare un’azienda che ha perso primato delle tecnologie, fiducia degli investitori, e tacciamo dell’entusiasmo dei dipendenti su cui pende la scure del licenziamento in massa. All’epoca voci critiche si erano levate, anche in ambito tedesco, sulla decisione di affidarsi a Intel ma coinvolgere altri attori con tecnologie avanzate, ma non vennero ascoltate.
In Italia gli investimenti si sono focalizzati su due azioni, assai diverse fra loro, complementari rispetto agli sviluppi delle tecnologie più scalate per circuiti integrati su silicio (come quelle in previsione in Germania o in Francia), ma non meno importanti. A giugno 2024 è stato annunciato dal ministro Urso il progetto da 3,2 miliardi di euro per la realizzazione a Novara di una fabbrica di Silicon Box, start-up “unicorno” nata a Singapore e dedicata all’assemblaggio secondo procedure innovative dei chip di silicio (chiplets). A Catania si svilupperanno sia una linea pilota, che coinvolge anche CNR e Atenei, che una vera linea di produzione di STMicroelectronics a 200 mm (con 5 miliardi di investimenti), per componenti su carburo di silicio, semiconduttore ad ampio energy gap la cui rilevanza sta crescendo di pari passo con le richieste per sistemi efficienti di conversione dell’energia elettrica, a partire dal mercato delle auto elettriche e delle energie rinnovabili. In entrambi i casi nel 2024 la Commissione Europea ha approvato i finanziamenti statali per sostenere la realizzazione delle opere, che saranno anche finanziate privatamente dalle aziende coinvolte e che si prevede saranno pienamente operative verso il 2033.
Anche in questo caso, sfortunatamente ma non sorprendentemente, in Europa ogni stato ha trattato separatamente con aziende private per attrarre investimenti per la realizzazione di fabbriche di semiconduttori, in competizione con gli altri paesi europei, senza capacità – o reali possibilità – di coordinamento da parte degli organi di Bruxelles. In questo scenario frazionato, agitato da spinte nazionaliste, in balia di decisioni di attori di prima grandezza (USA e Cina, ma anche gli BRICS stanno emergendo a partire dai 15 miliardi di dollari di investimenti dell’India), è da augurarsi che l’obiettivo di aumentare la produzione di chip in Europa sia mantenuto dalla Commissione e, soprattutto, dai vari paesi. Le affermazioni di principio – i semiconduttori sono alla base della competizione tecnologica globale – ribadite più volte in Europa dovrebbero concretizzarsi in una politica industriale di lungo termine, anche a fronte di congiunture temporaneamente sfavorevoli. Dovremmo essere ben consapevoli sia dell’importanza del settore che della sua volatilità – ha avuto un calo nel 2023 dopo il boom del 2022 ma ha recuperato ai valori del 2023 lo scorso anno e le previsioni sono per una crescita nel 2025. Abbiamo già perso in passato aziende importanti per miopia politica e limiti aziendali, e altri paesi ne hanno ampiamente approfittato: confidiamo che non accada in futuro.
Cercheremo di seguire da questo osservatorio l’evoluzione tecnologica e geopolitica del mondo dei semiconduttori: il 2025 promette novità assai stimolanti, a partire dal 20 gennaio.
Alessandro Paccagnella